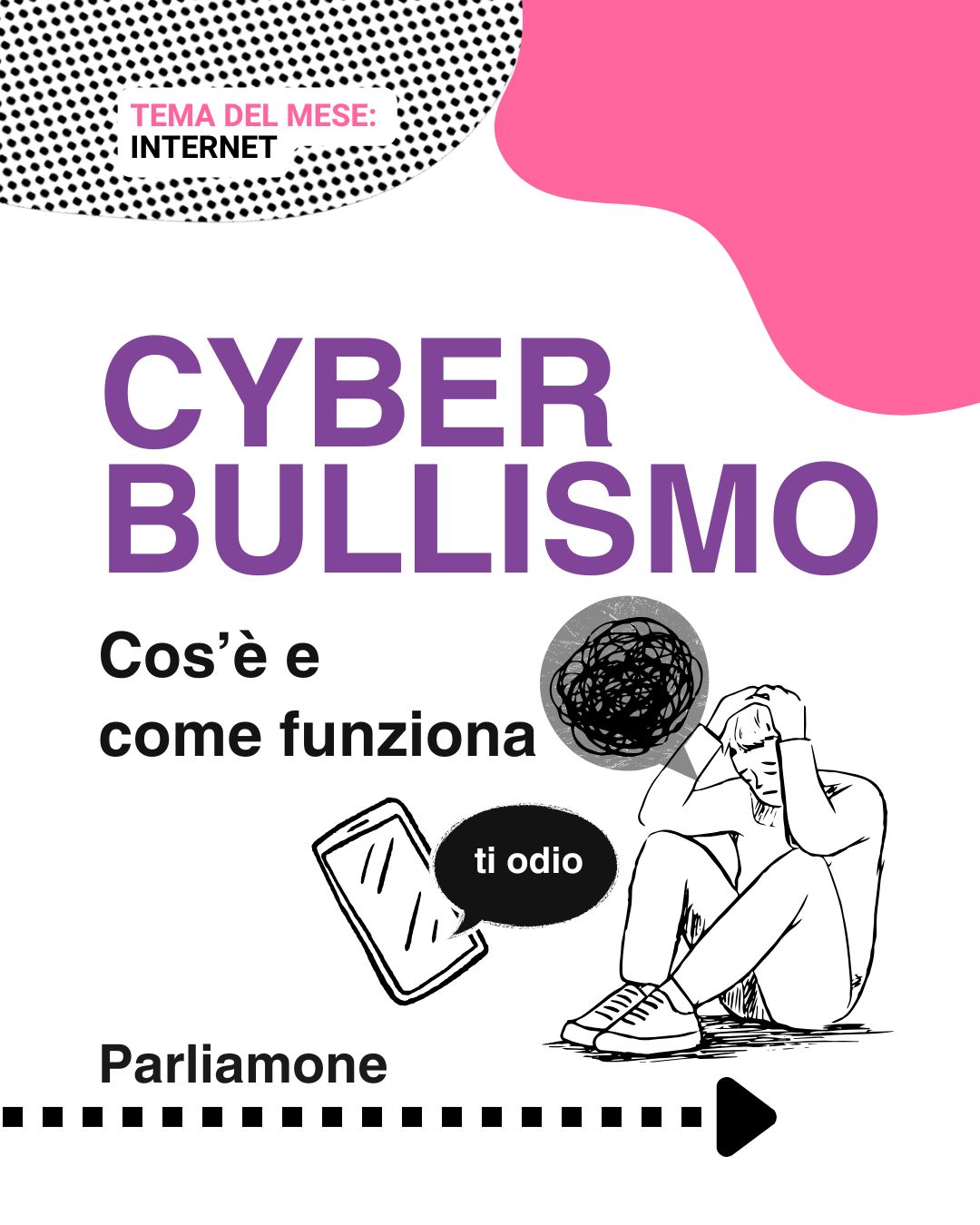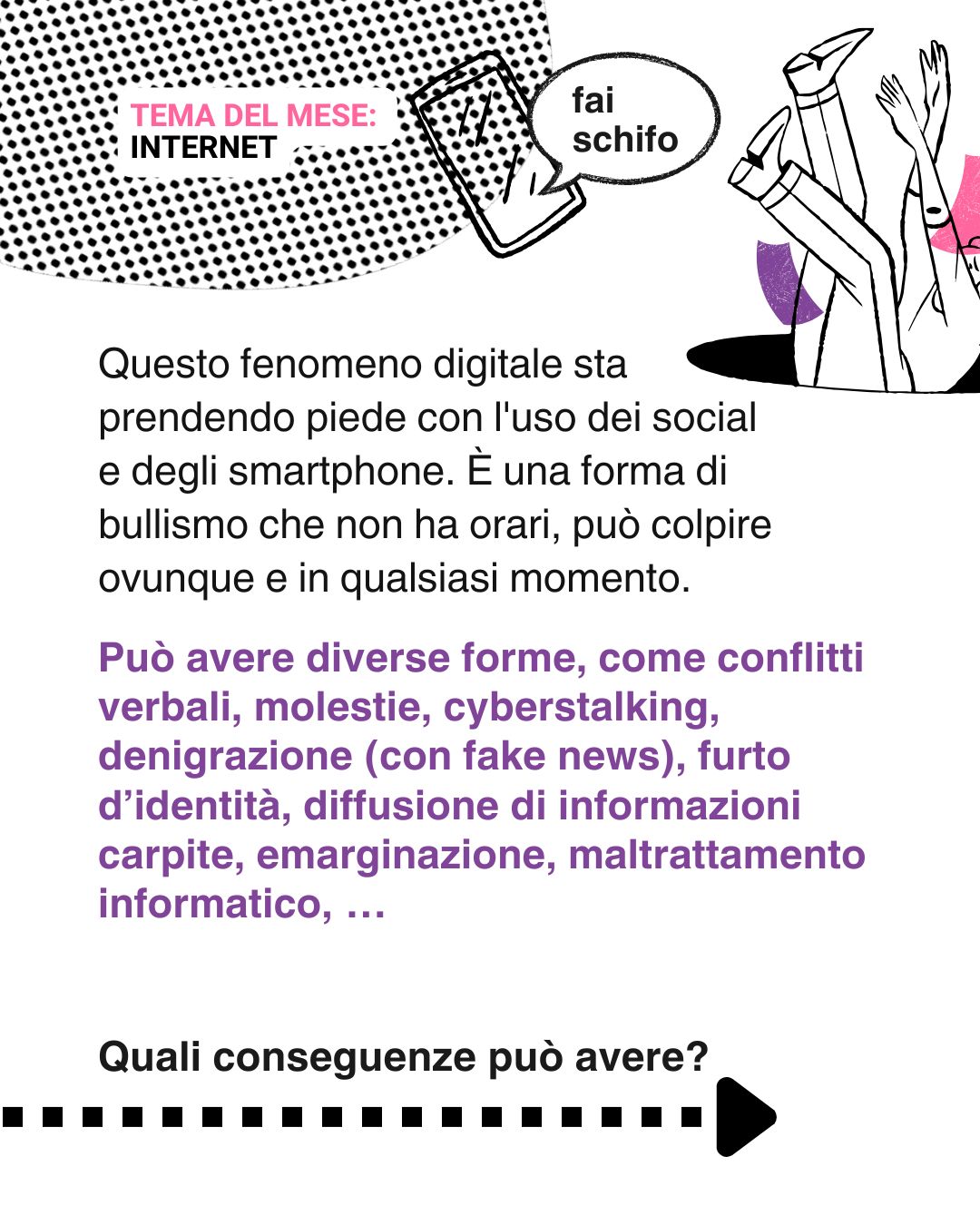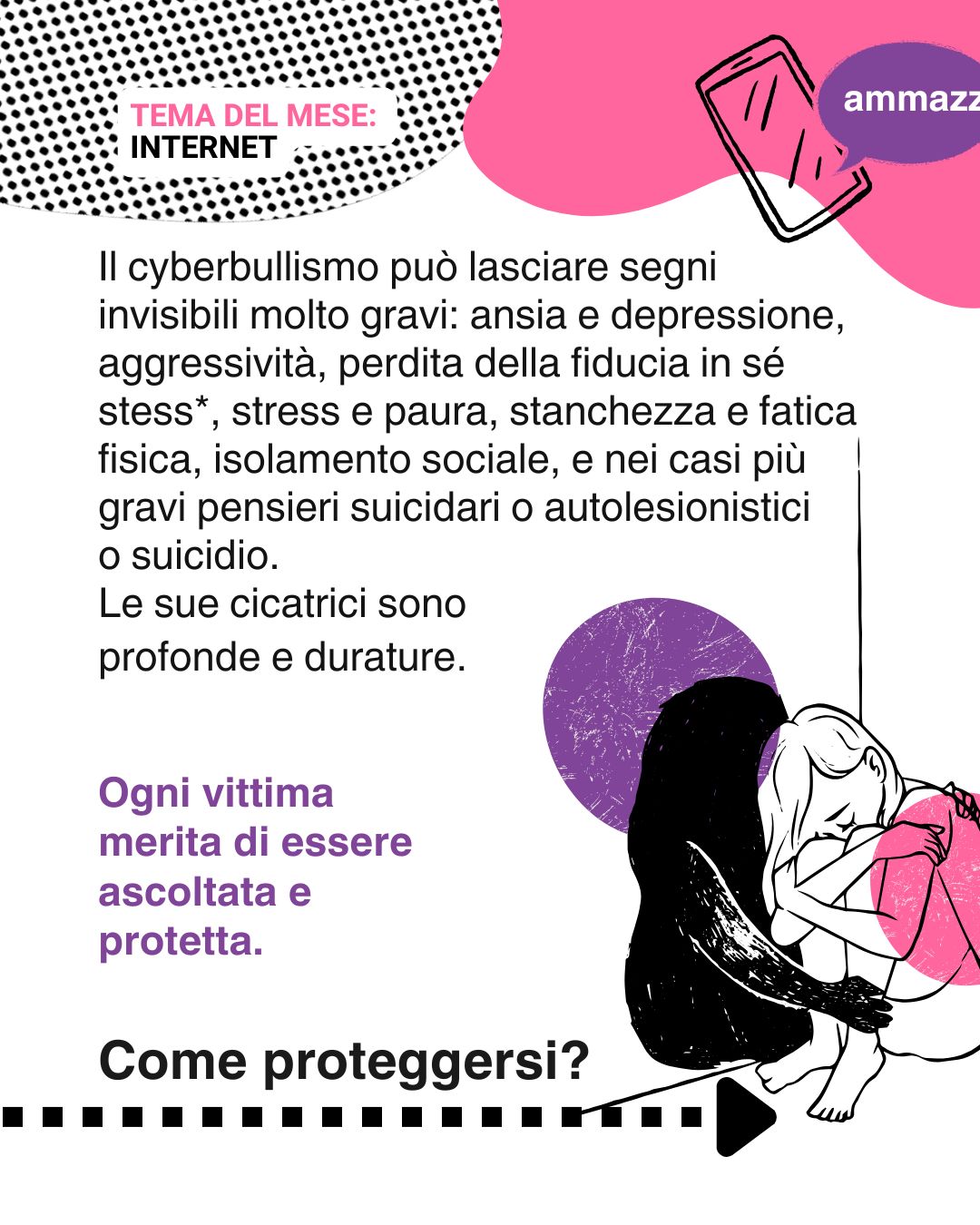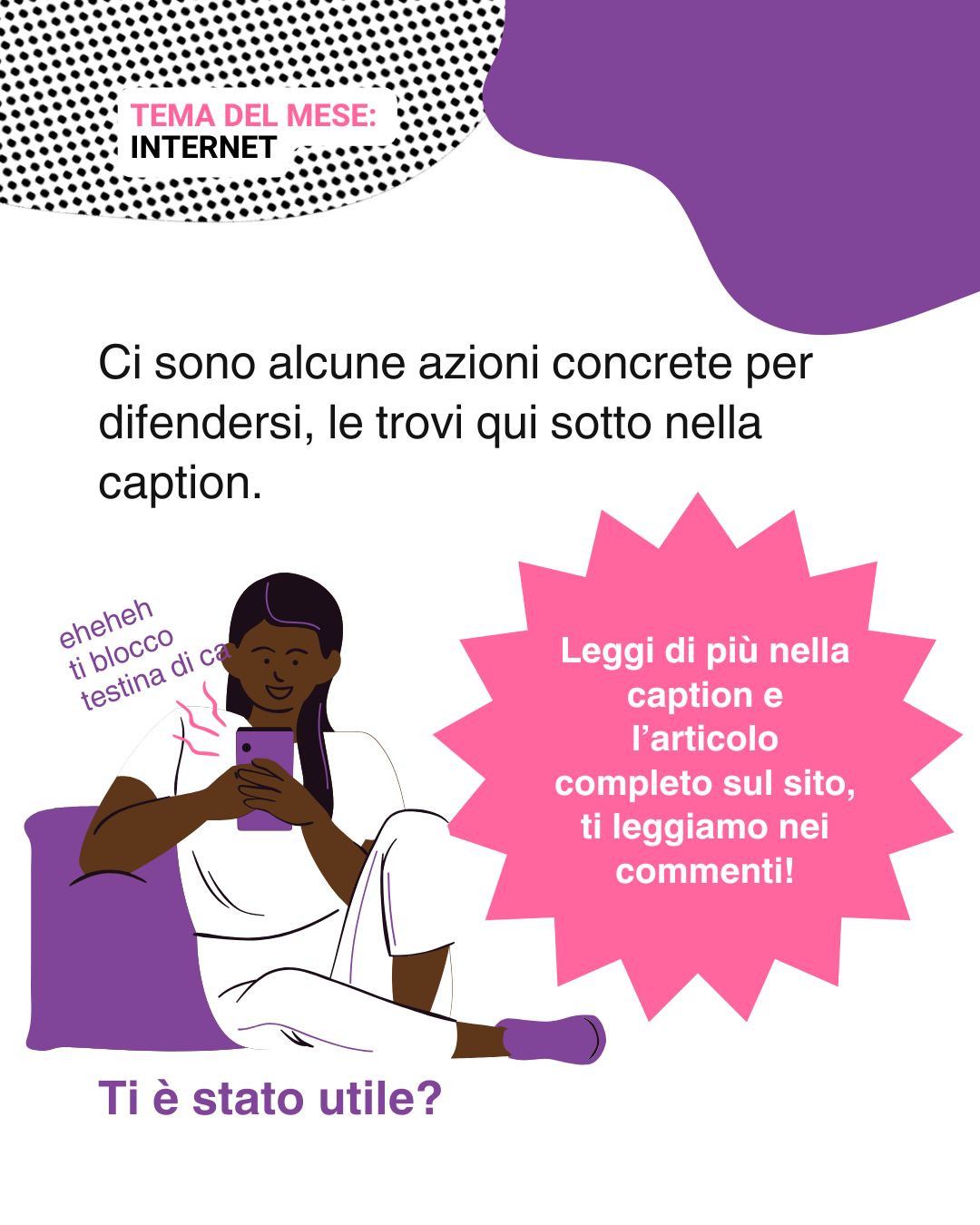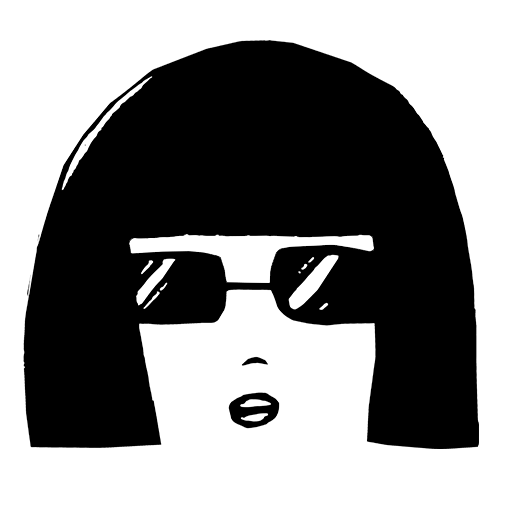Il termine cyberbullismo fu coniato dall’educatore canadese Bill Belsey nel 2002 e ripreso nel 2006 da Peter K. Smith e collaboratori.
Esistono molte definizioni di cyberbullismo, ma, se andate sul sito del Ministero dell’istruzione e del merito, troverete scritto che “il cyberbullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo. Quest’ultimo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico. Oggi la tecnologia consente ai bulli di materializzarsi in ogni momento perseguitando le vittime con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web e sui social network. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo”.
A differenza del bullismo, che ha bisogno di fisicità, il cyberbullismo può colpire in ogni momento, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno; inoltre, il suo impatto è spesso amplificato dalla diffusione immediata e globale del contenuto dannoso e dalla difficoltà di liberarsi da tali contenuti.
Ci sono diverse tipologie di cyberbullismo, che può essere diretto (quando i messaggi, le chat, le email hanno un effetto immediato sulla vittima) e indiretto (quando la persona che attua bullismo posta o denigra la sua vittima usando aree pubbliche della rete, dove i contenuti diventano pubblici e condivisibili): flaming (conflitti verbali) – messaggi elettronici violenti e volgari, mirati a suscitare battaglie in un forum tra due o più contendenti; harassment (molestie) – messaggi offensivi, insultanti, disturbanti, inviati ripetutamente nel tempo; cyberstalking (terrorizzare le vittime) – molestie insistenti e intimidatorie, tanto da ingenerare nella vittima timore per la propria incolumità fisica (in questo caso, può anche essere diffuso online materiale riservato e intimo); denigration (fake news, notizie false) – diffusione online di pettegolezzi e/o altro materiale offensivo, nell’intento di danneggiare la reputazione o le amicizie di una persona coetanea; impersonation (furto d’identità) – furto dell’identità di qualcun*, di cui si viola l’account o dopo aver ottenuto in modo consensuale l’accesso. La persona che attua bullismo si fa passare per la vittima, invia dal suo profilo messaggi o email, con l’obiettivo di danneggiare o compromettere la sua reputazione e la sua rete sociale; outing e trickery (diffusione di informazioni carpite) – diffusione di confidenze spontanee, immagini riservate o intime precedentemente salvate; exclusion (esclusione) – emarginazione della persona da un gruppo online; cyberbashing (maltrattamento informatico) o happy slapping (schiaffo felice) – pubblicazione online di filmati in cui la vittima viene picchiata e insultata al cospetto di un gruppo, che riprende la scena.
Le conseguenze per la salute della vittima possono essere molto gravi: ansia e depressione (chi subisce cyberbullismo può sviluppare sintomi d’ansia e depressivi, fino a rientrare a pieno in un quadro psicopatologico); aggressività; perdita della fiducia in sé stess* (il riflesso delle critiche e del bullismo si riversa su una visione negativa e pessimistica di sé e delle proprie capacità); stress e paura (ricevere messaggi minacciosi o vedere contenuti offensivi diffusi pubblicamente può creare un senso costante di paura e stress. La vittima può sentirsi insicura ogni volta che accede ai social, preoccupata di quello che potrebbe trovare e questa paura può poi estendersi anche alla vita offline); stanchezza e fatica fisica (non si tratta di effetti di diretti del cyberbullissmo, ma è la conseguenza di uno stato di forte stress prolungato); isolamento sociale (la vittima può iniziare a evitare i social o addirittura i rapporti con le altre persone per paura di essere ferita di nuovo. Questo isolamento spesso peggiora la situazione, aumentando il senso di solitudine e la vulnerabilità agli attacchi); pensieri suicidari (nei casi più gravi, il cyberbullismo può portare a pensieri suicidari o autolesionistici. La combinazione di umiliazione, isolamento e paura può generare un senso di disperazione, per cui è fondamentale intervenire prima che la situazione si aggravi); suicidio.
Per questi motivi l’intervento psicologico è fondamentale per dare un supporto concreto alle vittime.
Anche nei confronti di chi compie atti di violenza, la terapia psicologica offre strumenti per gestire aggressività e comportamenti devianti.
Il cyberbullismo si è sviluppato a seguito dell’ampio utilizzo dei mezzi di comunicazione online da parte di preadolescenti e adolescenti. La facilità di accesso a pc, smartphone, tablet consente al cyberbullo di commettere atti di violenza fisica e/o psicologica, anche in anonimato, mediante i social network. Secondo il rapporto Ipsos 2014 per Save The Children quattro minori su dieci sono testimoni di atti di bullismo online verso coetanei o coetanee, percepiti “diversi” per aspetto fisico (67%) orientamento sessuale (56%) o perché stranieri/e (43%).
Il bullismo è percepito dal 69% dei minori italiani intervistati come un problema più grave di droga, alcol e della possibilità di subire molestie da un adulto.
Con il comma 2 dell’art. 1 della legge 29 maggio 2017, il cyberbullismo può assumere la forma di un vero e proprio reato quando si configura come ingiuria, diffamazione, calunnia, furto d’identità, molestia e via dicendo, per non parlare di quando si verificano atti di vera e propria violenza verbale o fisica che sono poi ripresi e pubblicati online.
Per tutti questi frangenti, qualunque persona di età superiore ai 14 anni che commetta atti di bullismo può risponderne, affrontando conseguenze penali che variano a seconda della tipologia di reato. Al di sotto di quell’età, le conseguenze possono ricadere sui genitori.
Anche se non c’è stata denuncia, in caso di ingiuria, diffamazione, minaccia e trattamento illecito dei dati personali commessi via internet, e se il fatto avviene tra minori di età maggiore di 14 anni, il questore può applicare un ammonimento, convocando il/la minore e i suoi genitori.
Negli anni sono stati sviluppati strumenti e conoscenze che ci permettono di proteggerci dal cyberbullismo.
Si può non rispondere alle provocazioni e alle offese per non incoraggiare ulteriori attacchi.
Bloccare e segnalare chi attua bullismo tramite gli strumenti forniti dalle principali piattaforme social e di messaggistica, sia se il bullismo è rivolto a noi, sia se siamo testimoni di attacchi verso altre persone.
Conservare le prove, come messaggi, screenshot o e-mail che potrebbero essere utili in caso di denuncia.
Limitare la condivisione di informazioni personali come indirizzo, numero di telefono o dettagli privati.
Controllare le impostazioni di privacy in modo da rendere i nostri profili visibili solo a persone di cui ci fidiamo, riducendo così le possibilità di ricevere attacchi da persone sconosciute.
Parlare con un adulto di fiducia come un genitore, un/un’insegnante o un* psicolog* perché chi subisce cyberbullismo non deve affrontarlo da sol*, e una persona adulta può offrire supporto e guidare nella gestione della situazione.
Essere consapevoli delle nostre emozioni e cercare aiuto se il cyberbullismo ci sta creando difficoltà emotive, come ansia o tristezza, evitando di sottovalutare ciò che proviamo. Possiamo considerare di parlare con un/una professionista della salute mentale per ricevere aiuto nel gestire questi sentimenti e imparare a costruire strategie di resilienza.
Lavorare costantemente su di sé per sviluppare consapevolezza e sicurezza nella nostra persona e nelle nostre capacità. Una forte autostima e delle buone capacità emotive, cognitive e relazionali rappresentano la protezione più alta agli attacchi di bullismo in tutte le sue forme.
Ricordiamoci che chiunque può essere vittima di cyberbullismo: chiedete a Lady Gaga.
Chuchu